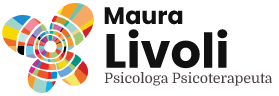L’Alessitimia: cos’è e quando nasce
L’alessitimia, viene messa in relazione con i disturbi da sintomi somatici, attraverso una nuova categoria diagnostica del DSM-5 (Manuale dei Disturbi di Salute Mentale ultima edizione), in sostituzione della classificazione precedente del DSM-IV° che la inseriva nei “disturbi somatoformi”.
In letteratura, si concepisce l’alessitimia come deficit della regolazione degli affetti e dell’elaborazione cognitiva delle emozioni (Taylor et al.1997) e fu proprio Grame J. Taylor che con il suo gruppo di ricercatori a Toronto elaborò uno strumento psicometrico affidabile per la validazione e la misurazione del costrutto, denominata la Toronto Alexithymia Scale (TAS- 20). Essa si presenta come una scala autosomministrata che agevolò la ricerca empirica su questo costrutto, sia per le corrette caratteristiche psicometriche che la contraddistinguevano, sia per l’elevata validità ed affidabilità riconosciute.
Le osservazioni cliniche effettuate su pazienti affetti da malattie psicosomatiche classiche da più di 40 anni (ulcera, asma, colite ulcerosa, eczema, ipertensione essenziale, dermatiti) e successivamente, anche su altre popolazioni mediche e psichiatriche hanno evidenziato quanto l’alessitimia abbia una base prevalentemente psicosomatica.
Il termine “alessitimia” significa ‘emozione senza parola’ o ‘mancanza di parole per le emozioni’ (dal greco: a= mancanza, léxis = parola, thymós = emozione). Il primo a studiare sistematicamente il costrutto fu Sifneos, che nel 1973 coniò questa parola “alessitimia”, per indicare quei pazienti che presentavano delle difficoltà nell’esprimere verbalmente i propri sentimenti, manifestando una certa attività fantasma pulsionale limitata ed uno stile comunicativo neutro, soffermandosi particolarmente sui dettagli degli eventi esterni senza alcun riferimento ai vissuti interiori, ai desideri, alle paure, agli affetti, alle emozioni (Sifneos, 1987).
Successivamente si stabilì l’esistenza di un’alessitimia primaria e secondaria. L’alessitimia primaria viene identificata come conseguenza di deficit neurobiologici, mentre l’alessitimia secondaria viene intesa come “una vera e propria strategia protettiva utilizzata di fronte a situazioni traumatiche intense e prolungate” (Freyberger, 1977), o ancora come risultato di un arresto dello sviluppo, legato a fattori socioculturali o psicodinamici (Sifneos, 1988).
Una successiva distinzione fu fatta tra alessitimia in quanto tratto di personalità stabile, e alessitimia in quanto disfunzione dipendente da uno stato patologico momentaneo e soltanto dopo la Conferenza di Heidelberg, ossia l’Undicesima Conferenza Europea sulle Ricerche Psicosomatiche, ebbe la definizione definitiva di “Alexithymia, pensée opératoire, psychosomatisches phänomen” nel 1976.
Attualmente, le caratteristiche dell’alessitimia sono:
A queste caratteristiche se ne sono aggiunte alcune non proprie del nucleo teorico dell’alessitimia (Taylor, 1997), quali: sintomi somatici; esplosioni di collera o di pianto immotivato; manifestazioni di rabbia; espressione delle emozioni tramite l’azione: la presenza di una difficoltà a mentalizzare (per mentalizzare si intende la capacità di sapersi rappresentare e comprendere gli stati mentali propri e altrui, inclusi sentimenti, credenze, intenzioni e desideri, costituendo il prerequisito fondamentale per la regolazione autonoma degli affetti) i propri stati mentali interni portando i soggetti alessitimici a regolare le proprie emozioni con atti impulsivi o comportamenti compulsivi (abbuffarsi di cibo, parafilie, abuso di sostanze); sogni raramente presenti che variano tra incubi arcaici e pensiero razionale (Apfel, Sifneos, 1979); impressione di pseudonormalità e ridotta empatia con difficoltà a riconoscere le emozioni proprie ed altrui e tale incapacità si traduce in una oscillazione tra comportamento dipendente ed evitante, nonché tra la scelta di sviluppare relazioni fortemente dipendenti ad alta interscambiabilità o isolamento dalla realtà sociale (Krystal, 1979).
L’alessitimia è un costrutto complesso, e pur essendo possibile distinguere le caratteristiche sul piano concettuale, risultano in realtà interdipendenti sul piano logico: l’incapacità ad identificare e comunicare i propri sentimenti è collegata all’incapacità di distinguerli dalle sensazioni corporee che sono insieme agli stati emotivi, in analoga modalità, uno stile cognitivo orientato all’esterno che riflette un’assenza di pensieri e fantasie. I soggetti alessitimici, pertanto, non riescono a tradurre in parole le proprie emozioni, intendendo l’espressione emotiva come operazione di elaborazione e non come scarica di pulsioni interne (Solano, 2001).
La comprensione dell’alessitimia necessita una distinzione fondamentale tra “emozioni” e “sentimenti”. Le emozioni, sono la componente biologica dell’affetto, mentre i sentimenti, sono la componente psicologica. Le emozioni precedono sempre i sentimenti e sono provocate da cose o eventi realmente presenti o ricordati dalla persona, e lo psichiatra Antonio Damasio nel 2003 chiama questi attivatori (triggers) stimoli ‘emotivamente competenti’, affermando che le emozioni vanno in scena nel teatro del corpo, mentre i sentimenti vanno in scena nel teatro della mente. L’alessitimia non indica individui senza emozioni, ma soggetti con un deficit della componente psicologica dell’affetto (sentimento), ossia persone che hanno emozioni (a livello biologico), ma con scarsa o nessuna possibilità di ricorrere a strumenti psicologici (immagini, pensieri, fantasie) per rappresentarle e comunicarle.
Secondo le teorie psicoanalitiche, la funzione di regolazione affettiva fornita dal caregiver–primario (in genere si tratta della figura materna) durante la primissima infanzia, determina la successiva capacità o incapacità del soggetto di regolare gli affetti così ha affermato Kumin nel 1996.
Se si parte dal modello freudiano del segnale-angoscia, si ipotizza una linea di sviluppo della regolazione affettiva che si protrae dall’iniziale mediazione da parte della madre dell’affetto infantile, nella fase pre-oggettuale (prima della consapevolezza riflessiva di sé e degli ‘altri’ intesi come oggetti separati, modello evolutivo), al successivo modello di Bion (modello delle relazioni oggettuali) in cui la madre attraverso la funzione di rêverie - la capacità di reverie della madre è l’organo recettore dell’insieme dei dati sensoriali riguardanti il proprio Sé raccolti dalla coscienza del neonato. Non essendo in grado di elaborarli da solo, attraverso l’identificazione proiettiva li evacua dentro la madre, affinché ella li digerisca e glieli restituisca carichi di senso, quindi ‘pensabili’, fornendo così alla psiche del bambino il materiale per i pensieri del sogno, e quindi la capacità di svegliarsi e addormentarsi, di essere consci e inconsci. (Bion, 1961, in Sarno, Epifanio, 1999) è sintonizzata empaticamente con il bambino. In questo modello, la madre riceve dal bambino elementi mentali non elaborati (elementi beta), insostenibili per lui, restituendoglieli trasformati in elementi mentali aventi significato sopportabile (elementi alfa).
Il pensiero di Winnicott e Kohut, successivamente, stabilì che la regolazione affettiva avviene tramite la mediazione dell’affetto attraverso l’oggetto transizionale (oggetto speciale, come un giocattolo morbido, verso cui il bambino sviluppa una dipendenza emotiva traendone conforto ogni volta che deve fronteggiare l’angoscia dalla separazione della madre) e/o l’oggetto- Sé (oggetto del mondo esterno percepito come parte del Sé e utilizzato per la regolazione di funzioni psicologiche vitali come tensione emotiva ed autostima, questa funzione è svolta in genere dai genitori attraverso la propria capacità empatica).
Infine, il modello della Mahler (psicologia dell’Io), stabilì che la mediazione dell’affetto è progressivamente internalizzata da parte dell’Io durante la sottofase di riavvicinamento della separazione - individuazione.
In questi modelli, il bambino non viene visto come passivo, bensì come parte attiva nella sua interazione con il caregiver. I due si influenzano a vicenda, creando una relazione di reciprocità di estrema importanza, dato che influenzerà non solo la dimensione degli affetti e quella cognitivo-comportamentale del bambino, ma anche la dimensione neurofisiologica. Il regolatore non è quindi il caregiver, ma la relazione tra i due. indipendentemente dalla teoria utilizzata per spiegarne lo sviluppo.
La regolazione affettiva è una regolazione psicobiologica; si tratta di un processo attivo, che non implica semplicemente il controllo delle emozioni, ma anche la capacità di tollerare affetti negativi intensi e prolungati, bilanciandoli con affetti positivi in modo autonomo, senza il bisogno di ricorrere ad oggetti esterni o acting comportamentali. Si inserisce, quindi, anche una componente intersoggettiva, dato che la “relazione con gli altri”, sviluppandosi seguendo lo stampo di quella instaurata con la figura di attaccamento primaria, fornisce una regolazione interpersonale degli affetti sia in senso positivo (induzione di calma, rilassamento) che in senso negativo (tensione, perdita, aggressività).
Un disturbo della regolazione affettiva determina nel soggetto l’incapacità di utilizzare gli affetti sia come segnale, sia come sistema motivazionale ed informativo riguardo i propri stati emotivi ed il rapporto con gli altri; quando gli affetti non riescono a trovare un’adeguata mediazione per essere rappresentati verbalmente o simbolicamente sono, il più delle volte, espressi somaticamente.
Questo fallimento può portare l’individuo a sviluppare una struttura alessitimica, ritrovandosi incapace di utilizzare l’espressione verbale per esprimere le proprie emozioni. Ciò può verificarsi sia a causa dell’instaurarsi di uno stile d’attaccamento insicuro tra infante e caregiver primario durante la primissima infanzia, sia a causa dell’interferenza di esperienze traumatiche in suddetto periodo (Krystal 1988).
Seguendo questa prospettiva l’alessitimia si identifica come “deficit della regolazione degli affetti”, diventando un fattore di rischio notevole per il riprodursi di malattie somatiche e psicologiche.
Dott.ssa Maura Livoli
Psicologo Psicoterapeuta Sessuologo Psicoanalista Consulente tecnico
Roma